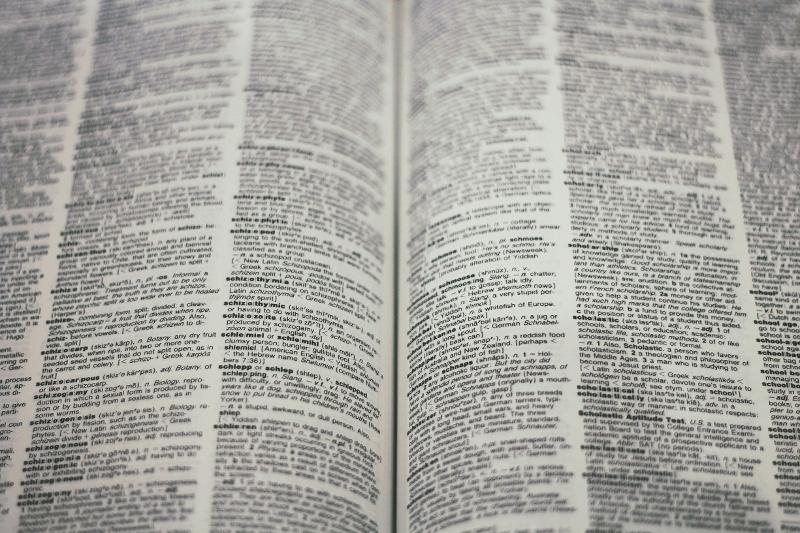L’ insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump ha riportato nell’informazione quotidiana il problema e le annesse soluzioni alla gestione dell’immigrazione e del diverso. L’ allarmismo, con il quale il tema è stato risvegliato, ha ribaltato gli schemi abituali utilizzati per la sua amministrazione dai governi e dal giornalismo. La modalità standard di esposizione risulta prettamente scientifica, di stampo organizzativo-descrittivo: presenta i modi adottati per procedere con gli spostamenti delle masse, le modalità di organizzazione in loco, la gestione degli arrivi; il problema rimane il linguaggio con cui questo processo viene narrato attraverso i media, riducendolo a un dibattito polarizzato caratterizzato da quell'elemento emotivo che traina la massa: ill terrore per un improvviso pericolo.
L’allarme di uno stato di sicurezza apparente suona continuamente, e instillare questa sensazione con le parole è cosa comoda alla retorica politica. Che l'accoglienza, o in questo caso la non accoglienza, sia una questione linguistica è evidente, lo si apprende dalle parole utilizzate e da una prima analisi dei titoli: una moltitudine di avverbi come “non abbastanza”, “mai troppo”, “scarsamente”, “non sufficientemente” che non ammetteno alcuno spazio linguistico per una visione positiva dell’accoglienza.
Il livello di analisi successivo è meno evidente di quello legato ai termini, e riguarda la loro comprensione da parte del pubblico. La logica dietro la retorica polarizzata prevede che l’opinione pubblica si scinda in due categorie incapaci di comunicare tra di loro, sovvertendo l’elementare schema dialettico in cui le due parti in gioco si accordano in una sintesi, ma così facendo rimangono una contro l’altra e ciò conviene a chi detta politiche di controllo. Le arringhe da piazza si basano su questo meccanismo binario: il tema centrale viene presentato sotto due possibili punti di vista, uno solo dei quali è corretto e l’altro sbagliato, lasciando così un ascoltatore o lettore più critico privo del suo spazio di riflessione, che è il motore di un’opinione pubblica attiva e consapevole.
L’effetto di reclusione tra due sole vie è generato non solo a livello retorico, ma anche tramite una subdola considerazione binaria dei significati delle parole che costituiscono il discorso. Scegliere un termine significa usarlo nella consapevolezza della sua moltitudine di significati, che continuano a esistere anche quando è necessario restringere il campo e preferirne uno in particolare.
Chi sfrutta in modo polarizzato il lessico applica invece all’uso e alla comprensione dei termini, un metodo usato in semantica, detto componenziale: ogni parola è disgregabile in componenti di significato più piccole a cui viene attribuito un valore positivo o negativo, che combinate tra loro definiscono la parola. Ad esempio la parola cane e così descritta: animale +; peloso +; amichevole +; felino -; carnivoro +; ammaestrabile +.
La criticità di questo metodo sta nella sua applicazione a parole ben più ampie e che eludono da una divisione standard delle categorie, come la parola "migrante". La Treccani suggerisce come significato “chi emigra o si sposta cercando nuove sedi", agli occhi dell'opinione pubblica e dei media le categorie che lo compongono si riducono quasi sempre a +/- civilizzato, +/- simile a me, +/- pericoloso, +/- pauroso, +/- utile, tralasciando il bagaglio enorme di significato che la parola porta con sé oltre un primo sguardo.
Sfruttare subdolamente questi schemi è una manipolazione della realtà e degli spazi di libertà di cui la comunità ha il diritto di avvalersi. I termini dell’umano sono carichi di un patrimonio di storie personali, culturali e sociali la cui comprensione è linguisticamente laboriosa ed emotivamente impegnativa. Limitare lo spettro di interpretazione conviene solo a chi vede nell'accoglienza un pericolo. Un paradosso, se si pensa che è proprio quella realtà interconnessa che ora viene sfruttata per una semplificazione di concetti che ci rendono sempre più lontani, che restringono sempre di più il momento personale di riflessione.
Esiste un tempo, quello della democrazia, che deve essere lento e che mal si adatta alle nuove prospettive della velocità e dei metodi economici di analisi del mondo, il cui risultato sono posizioni sempre più attufate e polari, riduzioni di significati e povertà di lessico, l’incapacità di comprendere la realtà.