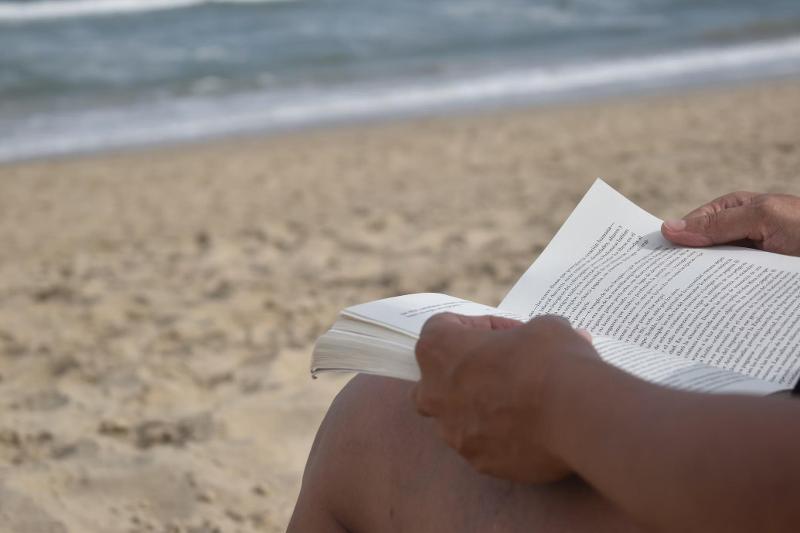In Italia non siamo mai stati grandi lettori, anche se la tradizione letteraria e culturale ci suggerirebbe il contrario, ma il mondo richiede sempre più prestazioni, la vita si risolve caoticamente e l’uomo perde il desiderio di approfondire la realtà.
Gli scenari futuri rattristano: i notiziari suggeriscono che l’odio governa la politica, il lavoro è sinonimo di monotonia, l’insoddisfazione spinge a vivere nella speranza di quello che sarà e niente di oggi è una lezione da cui imparare per domani. Ai giovani viene richiesto di non avere tempo per niente, di dover fare carriera, di lavorare fino a tardi, di impegnarsi a essere più di successo, più felici, più ricchi, più attivi, più tutto perché un giorno l’impegno sarà ripagato. L’illusione più grande che la società abbia potuto generare, eppure è la scelta più subdolamente economica che possa venir richiesta agli uomini.
Che la situazione sia critica ma non catastrofica lo suggerisce la stagione del “meriggiare pallido e assorto”, l’estate. Al mare il telefono aziendale non prende, il vicino di ombrellone si presenta commentando ad alta voce con la moglie che “la fila al bar è comunque meglio della metro alle 17, che dici?”. Nello zaino della montagna c’è la borraccia, l’Arnica, il panino con lo speck e il formaggio e “il libro regalato dalla Germana a Natale, te lo ricordi Armando?”. La voglia d’estate è la dimostrazione che ancora vogliamo essere felici e che ci ricordiamo di come era la vita quando il tempo e lo spazio erano nostri.
Le vendite delle librerie in estate migliorano - l’aumento non fa recuperare la penuria di acquisti annuali- ma d’estate diventiamo tutti lettori e questo fa onore al misero senso di umanità che riserbiamo per il mondo. Mallarmé scrive che “tutto sfocia in un libro”, che è la traduzione moderna di ciò che dice Omero, o chi per lui, nell’Odissea ovvero che gli dèi tessono disavventure per gli uomini affinché le generazioni future abbiano qualcosa da cantare. I Greci parlano di generazioni che cantano, Mallarmé di un oggetto, che nasce tra l’altro come oggetto personale, ma l’idea è la stessa: siamo fatti per l’arte, per la memoria, per la poesia come per l’oblio e la nostra richiesta di lentezza dimostra quanto ci teniamo.
Staccare, invertire la rotta quotidiana, dire di no sono spazi di rifugio e libertà tutte personali che chi legge conosce bene. La letteratura è fondata su un semplice e banale patto tra scrittore e lettore: credere nella finzione della realtà scritta nel libro. Chi legge è in grado di scappare dal mondo con un articolo di giornale, con un romanzo, con una raccolta di poesie e la fuga non è un egoistico disgusto per la quotidianità ma la battaglia di chi all’umanità tiene per davvero.
Ultimamente mi torna in mente spesso un passo di Jorge Luis Borges, suona così: “perduta per sempre Beatrice, Dante gioca con la finzione letteraria di ritrovarla”. Dante non è il solo a giocare con la letteratura per immaginare una realtà che non esiste, sicuramente migliore di quella vera, ma lo facciamo tutti quando leggiamo o quando riprendiamo il tempo e lo spazio che ci spetta. Non saremo auctores della finzione, ma spettatori sognanti sicuramente. Il passo citato, dolce nel pieno rispetto dei toni danteschi, va ben oltre l’umana pietà nei confronti di un innamorato che affida alla poesia il compito di riconquistare la propria felicità. Borges ci insegna che in quanto uomini, l’arte è il luogo della libertà, lo spazio più personale ed espugnabile dove tutto è possibile, da noi ingovernabile. L’uomo si munisce di strumenti che sono estensioni del suo corpo: un microscopio e un telescopio della sua vista, un telefono della sua voce, un aratro o una spada delle sue braccia ma vive per uno che solo della sua memoria e immaginazione è l’estensione.